18/07/2025

Oggi (14 dicembre 2009) è il novantesimo compleanno di Guruji; Guruji è per noi oggetto di immenso rispetto, devozione ed ammirazione, oltre la nostra capacità di espressione. Chi lo conosce personalmente può capire, la soggezione che può suscitare, il privilegio di studiare in Istituto e cercare la sua approvazione. Guruji è un grande yogi e una persona eccezionale e siamo felici di essere qui, con lui, nel giorno del suo compleanno.
Molti di noi erano presenti al compleanno scorso, molto importante, ed ora, per tutti, un anno è passato, siamo tutti più vecchi di un altro anno, ed è il momento di chiederci che cosa abbiamo imparato. Oggi sento il desiderio di rivedere con attenzione gli insegnamenti di Guruji ed esprimere i miei pensieri a voce alta:
Cosa insegna Guruji?
Che cosa noi impariamo da Guruji?
In che modo l’essere associati a lui ha contribuito alla nostra vita?
In che modo il mio apprendimento ha contribuito alla mia vita?
Vorrei inoltre condividere con voi un episodio che mi è capitato quest’anno. Una mattina stavo praticando marīchyāsana, una torsione, proprio qui in questa sala, e Guruji mi ha rivolto uno sguardo severo: “Quando imparerai?” mi ha chiesto. Sono rimasta sorpresa. Guruji aveva insegnato marīchāysana il giorno prima e io stavo ripetendo per esercitarmi.
“Guruji, sto mettendo in pratica il tuo insegnamento di ieri”.
“E tu rifai la stessa cosa di ieri? Perché lo yoga non ti entra nella testa?”.
Io non sapevo cosa rispondere e ho solo fatto un sorrisetto.
Mi ha girato le spalle per andarsene, poi è tornato sui suoi passi e con tono preoccupato, turbato, ha detto:
“L’abitudine è una malattia”.

Io sono rimasta sconvolta da quello che avevo sentito e dal modo in cui si era espresso. Stavo eseguendo lo stesso marīchyāsana che mi era stato insegnato il giorno prima e mi pareva di fare bene, ricordavo la sessione del giorno precedente. Come poteva essere sbagliato questo? Guruji aveva detto che rifare quello che aveva spiegato in precedenza era una malattia, come è possibile?
Come può l’abitudine essere una malattia? Se Guruji si era espresso così non potevo certo fare finta di niente, ma ero confusa, sbigottita e piena di domande. Se mi lavo i denti tutti i giorni è una malattia? Sono abituata a svegliarmi ad una certa ora, poi praticare. E allora? Ci doveva essere una spiegazione se Guruji aveva pronunciato quelle parole. Che cos’è l’abitudine? Che cos’è l’assuefazione?
Secondo il Chambers Dictionary, abitudine (habit) è “la tendenza ad agire o comportarsi in un determinato modo; il processo di diventare abituato; la tolleranza acquisita ad un farmaco, che da quel momento perde efficacia; la dipendenza psicologica ad un farmaco”.
Secondo l’Oxford Dictionary, la malattia (disease) è (tra l’altro): “una particolare qualità o disposizione vista come nociva per una persona o un gruppo di persone”.
Quindi, sono abituata? Sto sviluppando dipendenza psicologica? Si tratta di qualcosa di nocivo, non solo per me, ma per tutti? Imparando da Guruji, da Geetaji, da Prashantji forse sto cadendo in una trappola…di malintesi e interpretazioni sbagliate?
“L’abitudine non richiede un processo cosciente di pensiero per realizzarsi”
A pensarci bene, l’abitudine è la conseguenza di qualcosa che si realizza indipendentemente da un mio processo cosciente di pensiero; quindi, è indizio di una mia maniera annebbiata di pensare.
YS, II.18 prakāśa-kriyā-sthiti-sīlam bhūtendriyātmakaṁ bhogāpavargārthaṁ drśyam
La natura e le sue tre qualità. tamas, rajas e sattva, con le sue modificazioni, gli elementi, la mente, gli organi di azione e quelli di percezione, esistono eternamente per il per godimento o per l’emancipazione. Bhoga è il piacere sensoriale e apavarga l’emancipazione da esso.
Tornando all’esempio di marīchyāsana, si può arrivare a bhoga o ad apavarga:
Quale intenzione (hetu) c’è dietro al mio marīchyāsana?
Perché faccio marīchyāsana?
Perché pratico?
Perché frequento i corsi di yoga?
Forse l’emancipazione non è per persone comuni come me, ma è per i santi, per i grandi saggi. Potrei dire che frequento i corsi di yoga per adhyātma, per acquisire conoscenza. Ma, ad essere veramente sincera, faccio marīchyāsana per eseguire una torsione, per sentire il piacere di girare, di afferrami le dita, di fare un movimento che fa bene al corpo. Devo ammettere quindi che lo faccio per bhoga, per il piacere.
Quando siamo abituati a fare qualcosa generalmente lo facciamo perché ci dà sollievo e piacere. Un’azione diventa un’abitudine quando crediamo che ne valga la pena, che ci paghi i dividendi. Invece se un’azione provoca disagio, ci abituiamo ad evitarla. Evitare il dolore secondo noi serve ad ottenere piacere e benessere. La vita da sempre si basa sul fatto che occorre uno sforzo per evitare il dolore e cercare il piacere.

Una volta Guruji mi ha fatto fare virāsana con i metatarsi su un’asta di acciaio e le ginocchia su mattoni di legno. Faceva male. Per quanto mi sforzassi, il corpo sembrava seguire le sue sensazioni e si rifiutava di entrare in posizione. Guruji mi ha detto di sedermi e io mi sono seduta, poi mi ha chiesto come stavo. Io ho risposto che sentivo molto male. E lui ha detto:
“Chi ti ha chiesto del dolore?”.
Io percepivo soltanto dolore, ma questo per Guruji non aveva importanza.
Siamo “abituati” a guardare al dolore solo in un modo, per cercare di evitarlo, sradicarlo, liberarcene. Per Guruji, il dolore ha un significato differente. Noi siamo soliti guardare al dolore come opposto a bhoga, al piacere. Guruji invece insegna a porre attenzione ai dolori che ci conducono ad apavarga, all’emancipazione, mentre noi siamo abituati a non prenderli nemmeno in considerazione.
La nostra equazione lineare della vita è semplice: il dolore provoca duḥkha, pena; il piacere invece crea devozione, attaccamento, abitudine.
YS, II.7 sukhānuśayī rāgaḥ
Il piacere porta al desiderio e all’attaccamento emotivo
YS, II.8 duḥkhānuśayī dveṣaḥ
L’infelicità porta all’odio
Ecco spiegato perché oscilliamo tra i due poli della dualità. Colleghiamo strettamente la malattia e le sue cause, ci muoviamo in un pensiero ad una dimensione, schematico. Mettiamo le cose sempre nello stesso schema perché ci fa comodo. (Noi indiani) Amiamo la pelle chiara al punto da considerare una malattia la pelle scura. Alto è buono, basso no. Grasso è brutto, magro è di moda. La nostra idea di quello che è bello o sano è ambigua e piena di preconcetti.
In realtà le cose non funzionano così. Preferiamo il nostro paśchimottānāsana o un paśchimottānāsana con il viso sulla caviglia? Preferiamo il nostro trikonāsana o un trikonāsana con la mano piatta a terra?

Un’altra volta Guruji mi ha fatto fare setubanda sarvangānāsana sull’apposito panchetto e mi spingeva le cosce in padmāsana. Mi sembrava di dover eseguire uttana padma mayūrāsana, una posizione che non ho mai eseguito e che mi terrorizza. Le mie gambe facevano resistenza alla pressione di Guruji che mi invitava invece a mollare. Provavo ad obbedire, ma il dolore ed ancora di più la paura del dolore, mi impedivano di farlo. Lui mi ha detto:
“Se hai male, piangi e basta. Quello che sta succedendo all’interno del tuo bacino è impareggiabile. Stai rompendo le barriere per far fluire l’intelligenza. Hai blocchi ovunque”.
A me veramente pareva di rompermi la schiena!
Infrangere una barriera è un’operazione di estrema difficoltà. Ci pare naturale fare quello che è facile e rinchiuderci nel nostro guscio quando il gioco si fa duro. L’abitudine è proprio una barriera, un blocco che ci impedisce di vedere ciò che può davvero essere.
Quindi il dolore o la paura del dolore mi stava impedendo di rompere la barriera. Ma noi sappiamo che cos’è in realtà una barriera? Sappiamo comprendere se ce n’è una? Molto spesso non siamo in grado di percepire un blocco come tale, lo chiamiamo sicurezza, sistema, protezione, prudenza. Così siamo imprigionati nei nostri pensieri! La sicurezza diventa il nostro carcere! Il marīchyāsana di ieri mi aveva creato un blocco e non riuscivo neppure a vedere un diverso marīchyāsana oggi.
Penso che spesso non capiamo il linguaggio di Guruji nella maniera giusta, corretta, ma solo nel modo in cui ci siamo attrezzati a capire. Occorre sviluppare nuovi recettori, l’abilità di guardare dentro le parole di Guruji.
Una volta mi ha chiesto di eseguire uttanāsana in piedi su uno sgabello con le dita che sporgevano oltre il bordo. Guruji ha detto:
“Osserva quanta paura c’è, lascia andare. C’è paura nell’alluce, apri l’arco dell’alluce”.
Da queste parole ho recepito l’istruzione tecnica dell’alluce, ma ho ignorato il suo ordine di osservare la paura. Così si trascura quello che davvero può far progredire sulla strada della comprensione e dell’evoluzione. Si tratta di una negligenza, non di un qualcosa al di là delle nostre possibilità.
La nostra mente è stretta dai dualismi di dolore e piacere, comodità e disagio, giusto e sbagliato, sicurezza ed insicurezza, corretto e scorretto. Scegliamo quello che crediamo essere giusto e siamo “abituati” a giudicare sbagliata l’opzione opposta. Guruji mi ha detto che nell’esecuzione degli āsana stavo solo cercando di gratificare i miei sensi e che così ero lontana dallo yoga.
Cerchiamo quindi di analizzare l’”abitudine” da tre punti di vista: personale, sociale e cosmologico.
Abitudini personali. Un giorno a pranzo con Guruji alcuni allievi avevano portato dei jalebi (dolcetti indiani). Guruji utilizza sempre i regali degli allievi, 95% delle volte almeno. Una volta ha utilizzato un paio di orecchini che gli avevano regalato, regalandoli a me…
Io mi ero rifiutata di prendere i dolci perché non mi piacciono. Guruji mi ha chiesto come mai dicevo così, io ho ripetuto che sapevo bene che non mi piacevano. Lui ha detto:
“Forse l’ultima volta che hai mangiato un jalebi non ti è piaciuto, ma questa non è una regola per cui i dolci non ti piacciono. Come puoi avere questa presunzione?
Effettivamente, avevo permesso che i ricordi del passato modellassero il mio sentire del presente. Così siamo “abituati” a rinforzare i nostri blocchi a causa dei ricordi.
YS, I.11 anubhūta-viṣayāsampramoṣaḥ smṛtiḥ
La memoria è il recupero non modificato di parole ed esperienze.
Che cos’è la memoria? Mettiamo alcune cose nel magazzino della nostra testa, ed altre, inconsciamente, entrano da sole. Davanti ad un determinato stimolo, ci troviamo davanti le impressioni del passato. La memoria è una vrtti, un movimento della mente che ci fa recuperare i ricordi.
YS, I.5 vṛttayaḥ pañcatayyaḥ kliṣṭākliṣṭāḥ
Ci sono cinque tipi di movimenti della mente, riconoscibili o non riconoscibili, nocivi o non nocivi.
Dovremmo fare attenzione a quando la memoria ci fa capire se questi movimenti della mente sono kliṣṭa o akliṣṭāḥ. Nella maggior parte dei casi usiamo la memoria in modo automatico. Quando un certo stimolo richiama un episodio del passato, dovrebbe intervenire il nostro giudizio a valutare se questo ricordo è opportuno e utile nel momento presente. Di solito non lo facciamo: così pensiamo al futuro in base al nostro passato e compiamo le nostre scelte in base a rāga e dveṣa. Non ci piace qualcuno perché la memoria influenza l’informazione del presente e non ci curiamo di chiederci se quella persona meriti o meno il nostro apprezzamento. Scegliamo di praticare un āsana perché la memoria ce lo dice e lo evitiamo perché la memoria ce lo dice.
Insomma il nostro modo di funzionare ruota intorno al passato così come il mio marīchyāsana di oggi ruota intorno a quello di ieri. Questo si traduce in kleśaḥ, afflizione, se ci riferiamo ai ricordi kliṣṭa. Dobbiamo essere invece riconoscenti ai ricordi akliṣṭāḥ, altrimenti non ricorderemmo nemmeno Guruji!
In classe riusciamo raramente a cogliere il senso della lezione: registriamo nella mente quanto viene insegnato e la nostra memoria fa una scelta delle informazioni. Una volta, mentre mi insegnava paschimottānāsana, Guruji mi ha raccomandato di non farlo con il ricordo. Noi ci attacchiamo alla comodità e sicurezza che ci dà la memoria. Infatti io ero intrappolata dalla posizione di ieri.
Un’altra volta mi ha detto:
“Perché non ci pensi da sola? Perché devo continuare a ripeterlo?
Io ho cercato di spiegargli che non capivo come si potesse insegnare senza memoria e da dove venissero i suoi insegnamenti. La sua risposta è stata:
“I miei insegnamenti non vengono dalla memoria. La memoria è limitata, lo yoga è infinito. L’intuito mi guida nella posizione. Occorre praticare con un acuto senso di consapevolezza”.

Abitudini sociali. Prendiamo come esempio un semaforo (siamo in India!). Quando è rosso, alcuni di noi si fermano, altri hanno l’abitudine di violare le regole. Quando il semaforo diventa verde, alcuni prima di partire aspettano che lo faccia qualche altro automobilista. Qualcuno invece ha l’abitudine di suonare immediatamente il clacson appena scatta il verde. Seguire le regole o violarle è una questione di abitudine. Il seguirle ed esserne orgogliosi può trasformarsi in una fonte di sofferenza perché significa attaccamento, legame. Allora un’abitudine diventa kliṣṭa perché ci contrapponiamo a chi non segue le regole, e questo ci causa rabbia verso altre persone.
Possiamo dividere le abitudini in buone o cattive, ma ce ne sono in realtà di quattro tipi:
abitudini kliṣṭa buone
abitudini kliṣṭa cattive
abitudini akliṣṭāḥ buone
abitudini akliṣṭāḥ cattive
Abitudini “cosmologiche”. Prendiamo un esempio dalla nostra vita quotidiana. La maggior parte di noi conosce l’invocazione yogena cittasya, l’abbiamo recitata centinaia di volte. Ma l’abbiamo fatto con reale coinvolgimento ogni volta? Ascoltiamo davvero il messaggio dei maestri? Oppure pensiamo a quale posizione dovremo eseguire subito dopo, a spostare il tappetino, a che giorno della settimana è?
La preghiera è un mezzo per ricordare che siamo collegati con l’universo; invece per noi diventa un atto abituale, rituale. E’dunque la nostra “abitudine” quella di imbrogliare noi stessi?
Forse sto dicendo cose sgradevoli per alcuni, ma voglio davvero condividere questo pensiero.
Noi impariamo? Impariamo per davvero? Oppure prendiamo in prestito le illuminazioni e l’esperienza di Guruji e questo lo chiamiamo apprendimento?
Guruji dice: “Dovreste imparare ad usare la memoria in modo appropriato. Il ricordo ferma la possibilità di progredire e fa diventare stagnanti”. Noi eseguiamo gli āsana secondo determinati schemi. Per adho mukha svanāsana ad esempio abbiamo in testa un modello che dice gomiti stirati, scapole in dentro, lati del torace in su, cosce indietro. Applichiamo il nostro manuale di istruzioni all’esecuzione della posizione del momento. Facciamo un controllo a campione per vedere se abbiamo dimenticato qualcosa e spuntiamo quella voce dalla nostra lista mentale. Se resta tempo, ricontrolliamo lo schema una seconda volta. Ma in questo modo non stiamo limitando la nostra esperienza?
Ricordiamo Guruji:
” Il conosciuto ha dei limiti. L’ignoto è una vastità senza frontiere”.

Il nostro viaggio dentro un āsana deve portarci dal noto all’ignoto, non possiamo rimanere sempre allo stesso punto. Come possiamo uscire di casa se non apriamo la porta? Come possiamo assaporare nuove sensazioni ed esperienze se restiamo intrappolati in uno schema?
Un giorno, mentre eseguivo posizioni indietro, mi sono accorta che il mio sacro non era in posizione ma sono andata avanti lo stesso. Guruji mi ha vista e ha detto che avevo il sacro bloccato. A quel punto mi ha fatto fare degli archi indietro da in piedi, ma con le gambe ruotate in fuori, come Charlie Chaplin per intenderci. Mi ha fatto mettere le caviglie unite, gli alluci verso l’esterno, le gambe legate e il sacro appoggiato al bordo del cavallo, e dovevo inarcare e inarcare. Io ero spaventata, avevo paura di fare una cosa sbagliata, di compromettere la schiena.
Questi timori erano frutto degli avvertimenti della mia memoria. Ho fatto quello che mi chiedeva Guruji, ma poi la paura ha preso il sopravvento e ho chiesto come faceva questa modalità ad essere corretta. Lui ha sorriso e ha detto che in questo modo il mio sacro rispondeva meglio. Sono rimasta sconcertata dalla semplicità di queste parole. Avrei trovato più normale una lunga spiegazione tecnica, invece questa semplice risposta mi fatto avvertire la mia piccolezza. Uno sforzo complesso avrebbe coccolato il mio ego. E’ la complessità che soddisfa l’intelligenza o il cosiddetto processo intellettuale?
Una volta Guruji ha detto che si trattava soltanto di usare il buon senso, non era necessario essere dei geni. Insomma, ci si può permettere di girare i piedi all’esterno in urdhva dhanurāsana? Siamo chiusi in uno schema di giusto e sbagliato. Facciamo ciò che ci è comodo per abitudine e pensiamo di essere nell’ambito del “corretto”. Quando si sostengono opinioni “corrette”, in qualche modo sono la comodità e l’abitudine a trarne vantaggio e questo ci regala benessere e senso di piacere.
Prendiamo ad esempio l’allineamento. Un giorno Guruji mi ha detto di lavorare alle corde con una gamba avanti e l’altra indietro per attivare di più una scapola. Dovevo fare viparīta dandāsana con un piede più alto dell’altro per portare attenzione ad una natica. Cito questi episodi perché era proprio Guruji a dirmi che cosa dovevo fare, ma se non fosse stato lui a darmi queste indicazioni, come avrei reagito? Oppure, se avessi visto un altro praticante fare in questo modo che opinione mi sarei fatta? Io credo che avrei drasticamente rifiutato una cosa del genere.
L’apparente contraddizione di Guruji è risultato della sua sensibilità.
L’uomo a cui attribuiamo questo sistema di regole non pensa in realtà che questo sia un sistema chiuso dentro confini, ma un sistema aperto all’esplorazione. Noi invece ci appropriamo di alcuni concetti e li rinforziamo con i nostri pensieri; questi pensieri diventano ricordi e poi abitudini. Così diventiamo rigidi, credendo di fare le cose giuste e non quelle che riteniamo sbagliate. Chiediamoci: le nostre idee sono entrate nella zona di rigidità? L’abitudine nutre subdolamente la rigidità.
Pensate a quante volte Guruj ci dice che stiamo facendo in modo sbagliato mentre stiamo eseguendo una posizione convinti di fare esattamente quello che ci è stato insegnato in passato, secondo lo schema, l’insegnamento che proprio lui ci ha dato. Il fatto è che “giusto” e “sbagliato” sono concetti relativi, soggettivi e specifici rispetto al contesto. Ciò che è giusto per te, può essere sbagliato per me. Ciò che secondo me è giusto adesso può essere sbagliato domani. Il mio marīchyāsana di ieri è finito ieri. Oggi è un’altra storia.
Nelle lezioni Guruji ripete spesso:
“Gli āsana hanno perso il loro senso yogico a causa vostra. Praticate gli āsana per bhoga, così si sono trasformati in bhogāsana”.
Guruji insegna lo yoga e usa il corpo come metafora. Siamo noi ad intenderlo soltanto come corpo fisico, perché abbiamo l’abitudine di non ampliare il nostro orizzonte. Dovremmo imparare a decifrare il linguaggio di Guruji, a sviluppare i recettori dello yoga.
“L’abitudine è una malattia vera e propria. La cura consiste nell’essere aperti, sensibili e consapevoli”. Così i nostri āsana possono evolvere. E così possiamo intraprendere il viaggio da bhoga ad apavarga e questo può cambiarci la vita.
Come ha detto Guruj: “Apavarga è l’autoliberazione dalla prigionia”
Bibliografia:
Sridhar A., Habit is a disease, in “Yoga Rahasya”, 17, 2010, pp. 44-55.
https://www.oed.com/dictionary
Riferimenti immagini:
Asanas.fr; Sameer Karmakar; Yoga Source; Archivio AIYI
© Associazione Iyengar Yoga Italia (AIYI), luglio 2025
Via Leonardo Fibonacci 27 - 50131 Firenze
Tel. 055 674426
info@iyengaryoga.it
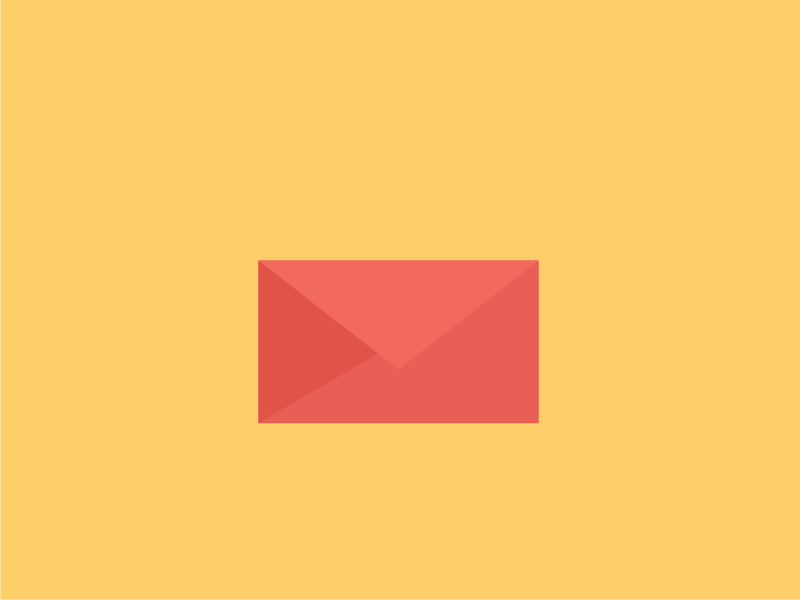
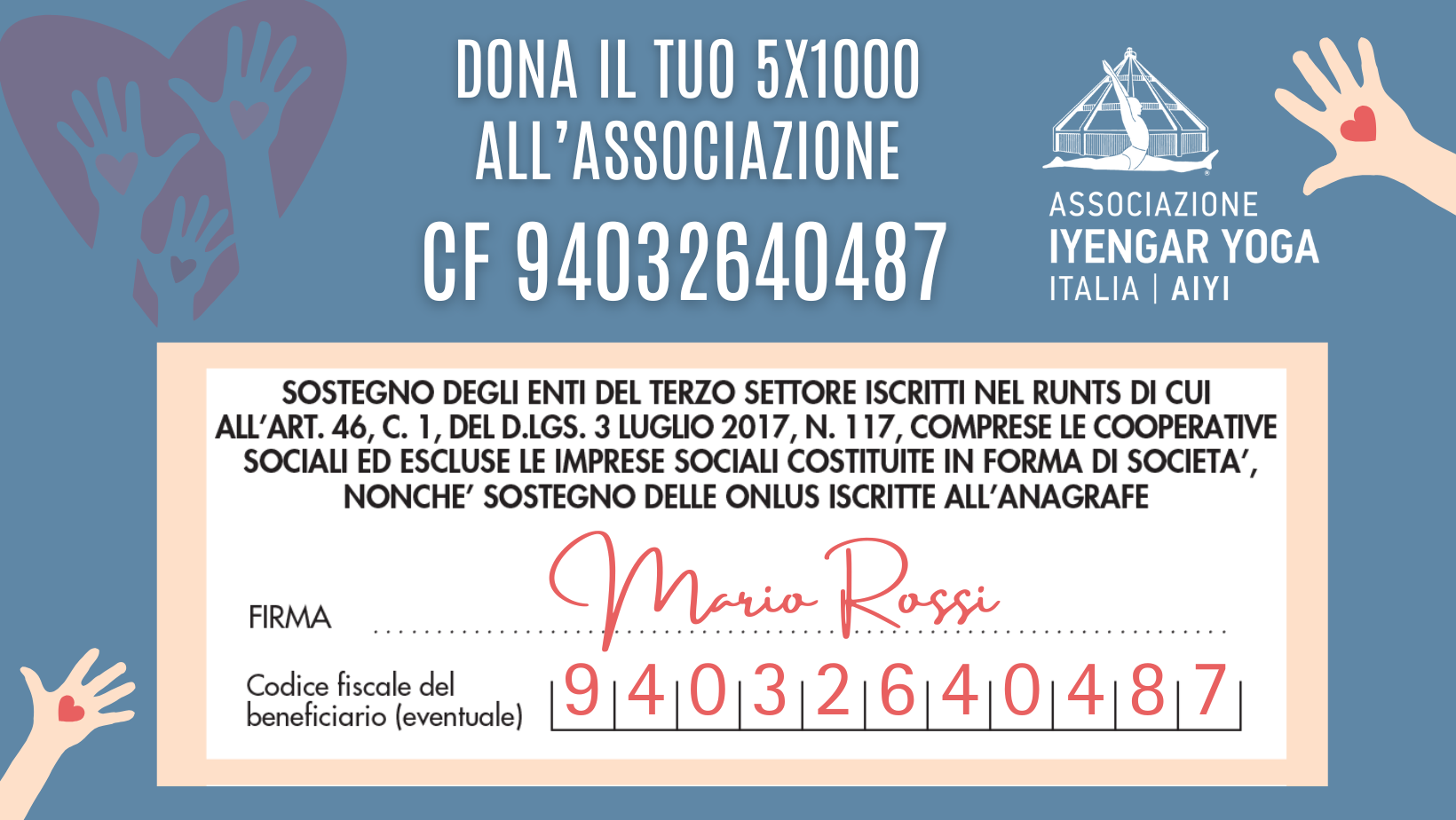
Via Leonardo Fibonacci, 27 • 50131 FIRENZE • Tel. 055-674426 • e-mail: info@iyengaryoga.it
Copyright © 2015 by IYENGAR® Yoga (Italy) • all rights reserved • privacy policy

