15/05/2025

Ancora oggi chi insegna IYENGAR® Yoga può sentire dagli allievi queste domande: una pratica yoga senza attrezzi è più in linea con la tradizione dell’haṭha yoga? Oppure, lo yoga non andrebbe praticato a corpo libero?
In numerose occasioni B.K.S. Iyengar e sua figlia Geeta hanno raccontato come sono nati i supporti, come sono stati ideati e sviluppati.
Ripercorrendo la storia dell’IYENGAR® Yoga si può vedere come l’introduzione dei cosiddetti props sia stata una delle tante innovazioni apportate all’insegnamento dello yoga.
B.K.S. Iyengar, e prima di lui il suo guru Krishnamacharya, si sono adoperati nella ricerca di un sottile equilibrio tra tradizione e innovazione grazie al quale lo yoga si potesse aprire al suo tempo, moderno e post-coloniale.
Esistono numerosi testi che raccontano la storia dello yoga e la sua evoluzione nel mondo moderno: studiosi quali Singleton, Alter, De Michelis, White hanno cercato di comprendere quali pratiche fossero maggiormente legate alla tradizione indiana dello yoga e quali invece fossero gli apporti occidentali della modernità. Gli stessi vorrebbero vedere nella nascita dello yogāsana una pratica fortemente connotata da contaminazioni con tecniche ed esercizi di tipo ginnico di vario genere, comprese quelle militari e del body building.
Si citano a questo proposito le immagini, nel testo di Singleton (M. Singleton 2010, pp. 58-63), che confrontano le posizioni assunte dal contorsionista, riportate nel libro di anatomia del 1889 di Thomas Dwight e da B.K.S. Iyengar (1918-2014).


Benché questi studi (di matrice anglosassone) abbiano messo in evidenza possibili inedite sinergie fra yoga e ginnastica, è possibile formulare un’interpretazione alternativa di tali similitudini basata sul criterio di convergenza culturale formulata, ad esempio, dallo studioso francese André Leroi-Gourhan (1911-1986) che aveva dimostrato che non è raro imbattersi in manufatti simili realizzati in tempi e luoghi diversi. Per spiegare questo fenomeno aveva parlato di convergenza tecnica, fenomeno che potrebbe applicarsi anche alle tecniche del corpo, tanto più che le stesse hanno alla base una comune fisiologia del corpo umano.
B.K.S. Iyengar, allievo di Krishnamacharya
Le fonti tradizionali, in particolare i numerosi libri scritti da B.K.S. Iyengar, raccontano come già nel palazzo di Mysore, dove operava Krishnamacharya, ci furono numerosi incontri con esponenti appartenenti sia al mondo della ginnastica che della medicina.
Questi scambi influenzarono la creazione di un nuovo equilibrio che consentisse alla tradizione dello yoga di rimanere viva e prolifica, così da continuare a destare l’interesse in nuovi adepti.
Infatti Krishnamacharya, nei suoi quasi sessant’anni d’insegnamento, modificò notevolmente il suo metodo e i diversi sviluppi intrapresi dai suoi noti allievi K. Pattabhi Jois, B.K.S. Iyengar e T.K.V. Desikachar testimoniano questa eterogeneità.
Seguendo la ricostruzione di Singleton (Singleton, 2010, pp. 186-221), nel 1931, Krishnamacharya, stimato studioso dei testi classici, fu invitato dal maharaja Krisnaraja Wodiyar IV (1884-1940) a insegnare al Sanskrit College (paṭhaśālā) di Mysore e due anni dopo gli fu assegnata un’ala del Jaganmohan Palace in cui insegnare yoga. Fu in questo periodo che B. K. S. Iyengar e Pattabhi Jois studiarono sotto la sua guida. Nel 1952 il maestro fu invitato a Chennai, dove rimase per tutto il resto della vita.
B.K.S. Iyengar fu a Palazzo dal 1934 al 1937, quando si trasferì a Pune, mentre Jois studiò con Krishnamacharya dal 1932 al 1953, anche se la sua frequentazione non poté essere assidua perché impegnato a insegnare al collegio Paṭhaśālā. Il maharaja di Mysore fu un mecenate eclettico che si prodigò sia per assorbire le innovazioni derivanti dall’occidente sia per promuovere la cultura indigena, soprattutto relativamente all’attività fisica.
È intuibile, pertanto, come Krisnamacharya dovette sperimentare diverse tecniche e metodi per rispondere alle esigenze del Maharaja, rinnovare la pratica dello yoga per renderla più appetibile soprattutto ai giovani e allo stesso tempo rispettare la tradizione.
Nell'India degli anni Trenta, infatti, lo yoga non aveva la popolarità di cui gode oggi; anzi era oggetto di scherno e disprezzo, era di moda tra i giovani di Mysore frequentare la palestra di K. V. Iyer (diretta da Anant Rao), mentre lo yogasálā di Krishnamacharya era considerato démodé: lo yoga era per i deboli, una pratica femminea a differenza della ginnastica virile di Iyer. Era inoltre considerato una pratica fisica per poveri, poiché disponibile gratuitamente.
L’insegnamento di Krishnamacharya, negli anni in cui B.K.S Iyengar studiò con il maestro, fu sperimentale, connotato da uno spirito di innovazione e di ricerca.
Singleton racconta che durante le lezioni di yoga, Krishnamacharya era sempre disponibile a nuove innovazioni e a modificare il suo insegnamento in relazione agli studenti. Inventava variazioni delle posture quando vedeva che alcuni dei suoi studenti potevano eseguirle facilmente. Inventava e innovava. Krishnamacharya non ha mai dato importanza a una particolare sequenza di posizioni, non c'era nulla di sacrosanto e non si era obbligati a rispettare una precisa sequenza da eseguire insieme a lui. Diceva però: “Pratica più che puoi”.
Questo spirito di continuo studio e ricerca lasciò nel suo giovane allievo B.K.S. Iyengar un imprinting che ha poi caratterizzato tutta la storia del suo insegnamento.
Iyengar rimase con il suo guru per circa due anni. All'inizio l’ācārya (maestro) non mostrò interesse nell'insegnargli gli āsana, probabilmente a causa delle sue condizioni fisiche. Fu nel 1935 che, in seguito alla dipartita di un ragazzo orfano cresciuto nella casa di Krishnamacarya, Keshavamurthy, che era stato da lui avviato allo yoga, avendo bisogno di formare un nuovo assistente che eseguisse gli āsana alla yogaśālā, il maestro concesse l’iniziazione ad Iyengar.
Nelle sue numerose biografie, B.K.S. Iyengar descrive il cognato come uomo di gran cuore ma di temperamento molto severo. Da ragazzo si sottopose così ad allenamenti estenuanti, mettendo a dura prova il proprio corpo, in parte per riconoscenza nei confronti dello yoga che gli aveva restituito la salute, in parte per compiacere il suo Guru e il Maharaja (B.K.S. Iyengar, 2001, p. 8).
Egli racconta, inoltre, dei numerosi incontri avvenuti sia alla yogaśālā di Mysore che poi a Pune, con altri guru noti internazionalmente, studiosi, medici, politici, musicisti e sportivi di fama ai quali insegnò a praticare gli āsana. L’apporto di questi confronti influì sull’evoluzione del suo insegnamento.
Nel 1937 Iyengar, iniziò la sua attività di “istruttore” di yoga a Pune, dapprima presso il Gymkhanain, poi indipendentemente, tenendo lezioni private.
Anche a Pune vi furono incontri con diversi maestri, tra cui quello con Swāmi Shivananda; è del 1946, invece, l’incontro con Krishnamurti, a cui iniziò a insegnare gli āsana. Iyengar menziona di aver applicato alle tecniche di prāṇāyāma “l’allertamento passivo” di cui parlava Krishnamurti, ossia quella passività che non è ozio, che non è sonno, ma estrema attenzione.
Nel 1952, quando la sua notorietà iniziò a varcare i confini nazionali, vi fu un altro incontro che incise in modo significativo sulla sua pratica di prāṇāyāma: quello con il violinista Yehudi Menuhin, che rimase così colpito da Iyengar da diventare suo seguace, facendolo conoscere anche in Occidente. Fu da questo famoso violinista, che Iyengar capì come appoggiare le dita sulle narici per il prāṇāyāma digitale.
B.K.S.Iyengar, inoltre, fu il primo a insegnare il prāṇāyāma anche da sdraiati per tutti quegli allievi che non riuscivano a stare a lungo nella posizione seduta. Se numerose furono le novità nella pratica del prāṇāyāma, ancora maggiori furono le innovazioni apportate alla pratica degli āsana, tra cui l’introduzione dei props.
Light on yoga, Yoga Kurunta e il perfezionamento dei props
Nel 1965 Iyengar pubblicò il famoso testo Light on yoga, e fu proprio in occasione di tale pubblicazione che si fece un’importante operazione di classificazione e nomenclatura delle posizioni, tanto che il libro rappresenta tuttora un riferimento imprescindibile. Tutti gli āsana sono eseguiti a corpo libero, senza props; di ognuno di essi viene spiegato il nome, la tecnica di esecuzione, e i benefici nel percorso dello yoga.
Al momento non risulta ancora possibile stabilire quali dei duecento āsana descritti nel libro appartengano a tradizioni, scritte e/o orali, indiane e se alcuni siano esito di “convergenza” o “prestito” (per usare ancora una volta le parole di Gourhan) da ginnastiche occidentali.
Sia Krisnamacharya che i maestri della famiglia Iyengar fanno riferimento, come fonte scritta, a un manuale perduto dal titolo Yoga Kurunta. Molti hanno anche dubitato dell’esistenza di questo manuale. Tuttavia, Jason Birch, all’interno del volume Yoga in Transformation, ipotizza un possibile collegamento tra Yoga Kurunta ed il manuale Haṭhābhyāsapaddhati. Infatti l’Haṭhābhyāsapaddhati ha pose con le corde, il che indica che le corde erano usate in questo modo nello yoga haṭha, forse già nel XVIII secolo. Nessuno dei nomi delle pose con la corda corrisponde a quelli del libro di Iyengar, ma un collegamento tra Haṭhābhyāsapaddhati e Yoga Kuruṇta sembra probabile, dato che il primo è l'unico testo di yoga esistente in cui sono state descritte pose con la corda... Finché non si troverà lo Yoga Kuruṇta, tuttavia, tali ipotesi rimangono speculative (J. Birch, 2018, p. 140).
Le corde, menzionate nel manuale sono, tuttavia, solo uno dei “supporti” introdotti nella pratica dello yoga di B.K.S. Iyengar.

Nella convention di Sidney del 1996, Geeta fece un lungo discorso sulla nascita dei props.
Dopo aver premesso quanto fosse stato difficile far accettare il loro utilizzo nel contesto indiano, cita due testi che, secondo lei, dimostrano come alcuni oggetti fossero già presenti nella tradizione dello yoga: Bhavagadgītā commentata da Rāmānuja (in cui si nomina la possibilità di un supporto per sedersi in meditazione) e, appunto, il libro Yoga Kuruṇṭa (in cui si nominano le corde).
Il nome Kuruṇṭa, in questo caso, viene fatto risalire al termine sanscrito kuruṇṭi a cui si attribuisce il significato di marionetta. Mio padre, racconta Geeta, afferma che nel libro erano presenti delle scalette in corda, mentre il suo guru utilizzava delle corde sospese con due anelli a cui appendersi.
Nomina inoltre l’Haṭhayoga Pradīpikā, in cui vengono descritti alcuni metodi per purificare il corpo, i ṣaṭ karmā (HY, II.21-22) e dice che gli yogi, seguendo i sei metodi di purificazione, usavano l’acqua in una piccola brocca oppure una benda di cotone per pulire il naso. Ovvero altri tipi di supporti, intendendo con ciò altri oggetti.
Geeta spiega infine come suo padre, Guruji, avesse pensato ai props non solo per aiutare gli altri, ma anche per sé stesso: “Durante la sua pratica Guruji pensava: io non riesco a fare quest’āsana e dovrei riuscirci. Se qualcuno mi sollevasse, spingesse, tirasse, allungasse o afferrasse, riuscirei fare meglio di così. A quel punto gli venne l’idea dei supporti”.

Sapeva, dice Geeta del padre, che appoggiarsi ad una parete era di grande aiuto per gli allineamenti e fu così che il muro diventò uno dei primi supporti.
Più in là negli anni, continua la figlia, Guruji si trovò ad avere a che fare con molte persone che si rivolgevano a lui per cercare di guarire dai loro malanni. Poiché Guruji aveva sperimentato che alcuni āsana, come le posizioni indietro, potevano essere di grande giovamento per particolari malattie, si interrogò a lungo su come fare in modo che tutti potessero eseguire posizioni complesse. Inizialmente aiutò con le proprie mani e le proprie gambe, usando dunque il proprio corpo come supporto, in seguito introdusse degli oggetti.
I supporti, conclude Geeta, hanno dato la possibilità di creare molte varianti agli āsana classici. Lo yoga di B.K.S. Iyengar si avvale così di un repertorio più vasto di posizioni che ha permesso di rispondere più puntualmente alle diverse esigenze dei singoli praticanti.
Lo stesso B.K.S. Iyengar, in una intervista (Iyengar, 1993, pp. 391-402) rivela come sono nati i props: “Tutti i supporti utilizzati oggi, come sedie, tavole inclinate, mattoni, sono innovazioni mie – dice Iyengar - tutte, tranne le corde sospese”. Il maestro racconta come inizialmente si preoccupasse di cercare vari modi per migliorare e perfezionare innanzitutto la sua pratica: “raccoglievo pietre e mattoni lungo le strade e li usavo come supporti e sostegni per migliorare nell’arte degli āsana. Certo, questi sassi e mattoni erano rozzi, grezzi, ciononostante in qualche modo mi erano d’aiuto nel padroneggiare gli āsana”.
E ancora: “Cominciai a usare qualsiasi cosa mi capitasse a portata di mano come sedie, scatole, letti, armadietti, pezzi di legno, rulli, pietre per macinare e così via. Ho imparato da quasi tutti gli oggetti domestici, ho usato perfino i serbatoi per l’acqua, quelli a forma di tamburo, per aumentare il tempo di permanenza negli āsana”.
In seguito, si avvalse di un falegname: “Lui mi portava i suoi manufatti allo stato grezzo, e io facevo varie prove di esecuzione degli āsana, consigliandogli di tagliare un po' qui, di aggiungere un po’ lì e così via. Il processo di riadattare e rimodellare ogni attrezzo andava avanti fino a quando non si arrivava al prodotto finale cui aspiravo”.
Nel corso del suo insegnamento costatò come i supporti fossero anche una guida per l'autoapprendimento, “un guru in assenza del guru”, e invitò i praticanti a confrontare i movimenti e le azioni indotti dall’utilizzo dei supporti con quelli che si eseguono quando si pratica senza attrezzi per comprenderne fino in fondo l’apporto.
Interrogato su quale fosse il beneficio più importante dei props, Iyengar rispose: “è quello di stimolare il corpo e la mente dei praticanti, di produrre quello zelo che invoglia a rimanere nelle posizioni sempre più a lungo e far sì che il sadhaka rimanga uno studente di yoga per tutta la vita”.

Le parole di B.K.S. Iyengar e di Geeta sono il modo migliore per rispondere alla domanda iniziale, ovvero se una pratica yoga che non utilizzi gli attrezzi sia più in linea con la tradizione dell’haṭha yoga.
Da esse, si evince che l’equilibrio raggiunto nel lignaggio di Iyengar tra la tradizione dell’haṭha yoga e l’innovazione non ha niente a che vedere con la pratica ginnica, presa a prestito dagli occidentali, mantenendo elementi superficiali della tradizione indiana (le invocazioni prima della pratica, i nomi delle posizioni accostati alla mitologia indù, ecc…) come insinuato tra le righe dei testi anglofoni citati.
Incrociando diverse fonti ci sembra invece di riconoscere un lavoro enorme da parte di questi maestri per trovare l’equilibrio tra la tradizione e ciò che la modernità chiedeva loro. Lo sforzo può essere compreso nella sua complessità solo dagli studenti che non si limitano a studiare le fonti o a fare ginnastica, ma si cimentano in una pratica che, attraverso la sua profondità, riesce a comunicare meglio delle parole il valore spirituale del percorso yogico.

Il preconcetto invece, che un lavoro a corpo libero sia, per rispondere alla seconda domanda, più autentico e di maggior valore, risente del primato attribuito dalla filosofia occidentale del ’900 alla tecnica, concepita come volontà di dominio e sfruttamento della natura da parte del soggetto.
Ad esempio, il filosofo contemporaneo Gehlen (1904-1976) evidenzia come il corpo umano venga al mondo incompiuto e, a differenza di altri mammiferi, come non sia autosufficiente e sia, invece, molto vulnerabile.
L’uomo, per lo studioso, si caratterizza proprio per i suoi limiti. Se l’evoluzione ha fornito gli esseri viventi della più alta specializzazione, l’uomo si distacca da questa linea evolutiva a causa della sua inadeguatezza, dovuta alla prematurità della sua nascita. Ed è proprio la sua prematurità che garantisce quella plasticità attraverso cui egli apprende dall’ambiente e lo modifica: una compensazione alla propria carenza biologica.
L’uomo, pertanto, carente alla nascita e conformato dall’ambiente, si adatta ad esso trasformandolo per assecondare i propri bisogni attraverso la tecnica. La sfera culturale è così l’habitat naturale dell’uomo.
Come dice un altro studioso della tecnica, Maldonado (1922-2018), tutti gli oggetti, non solo quelli che sostituiscono, completano o potenziano una determinata prestazione dell’organismo, possono essere identificati come protesi: protesi motorie (ad esempio i mezzi di locomozione), sensorio-percettive (ad esempio gli occhiali), protesi intellettive (ad esempio il computer) e protesi sincretiche, in cui i tre tipi di protesi confluiscono in un’unica e articolata aggregazione funzionale (robot).
L’haṭha yoga, portando, in alcune pratiche, il corpo in condizioni estreme (ad esempio allenando la capacità di resistenza per lungo tempo a temperature molto elevate), ha forse tentato in qualche modo, di percorrere la via di adattamento del corpo all’ambiente, la via del corpo autarchico.
L’Iyengar yoga, tuttavia, sembra aver imboccato la via “più naturale” per l’umano, ossia quella di aver accettato la propria incompiutezza e di aver ampliato i confini del corpo proprio attraverso quelli che Iyengar stesso ha nominato come props.
La pratica degli āsana con i props può allora descriversi come un’esperienza in cui, di volta in volta, la relazione tra il corpo e l’attrezzo si modifica rendendo possibili varie esperienze interocettive. Il confine tra dove finisce il corpo e dove inizia il prop, in alcuni casi, si perde (ad esempio tra il mattone e la mano in trikońāsana, dove il mattone diventa un prolungamento del braccio), in altri è così ben delineato (ad esempio con l’uso della panca in legno per eseguire viparīta daṇḍāsana, in cui una superficie rigida come il legno è in contatto diretto con il dorso della schiena, spesso altrettanto rigido) che si risolve in un ribaltamento dove, grazie all’oggetto, si scopre di avere una schiena, per lo più rigida, con buona pace della supremazia del soggetto sull’oggetto.
Bibliografia:
K. Baier, P. Maas, K. Preisendanz (a cura di), Yoga in transformation, Vienna University Press 2018.
J. Birch, M. Singleton, The yoga of the Haṭhābhyāsapaddhati: haṭhayoga on the cusp of modernity, in “Journal of Yoga Studies”, 2, SOAS 2019.
https://journalofyogastudies.org/index.php/JoYS/article/view/2019.v2.Birch.Singleton.TheHathabhyasapaddhati
E. De Michelis, A History of Modern Yoga. Patañjali and Western Esotericism, Continuum, London 2004.
A. Gehlen, L’uomo. La natura e il suo posto nel mondo, Feltrinelli, Milano 1983.
B.K.S. Iyengar, Adjustements in Practice, in “Aṣṭādala Yogamāla”, 7, Allied Publishers, New Delhi 2008, pp.313-326.
B.K.S. Iyengar, Iyengar, His Life and Work. CBS Publishers &Distributors, New Delhi 2001
B.K.S. Iyengar, Iyengar, His Life and Work . CBS, New Delhi 2001.
B.K.S. Iyengar, Teoria Pratica dello yoga, Edizioni Mediterranee, Roma 2003.
G. Iyengar (a cura di), 70 Glorius Years of Yogacharya B.K.S. Iyengar (Commemoration Volume), Light on Yoga Research Trust, Mumbai 1993.
G. Iyengar, Yoga per la donna, Edizioni Mediterranee, Roma 2005.
G. Iyengar, “Uso degli attrezzi nella pratica dello yoga” Sidney 1996 (Video)
M. Singleton, Yoga Body. The Origins of modern posture practice, Oxford University Press, New York 2010.
F. Squarcini (a cura di), Patañjali Yogasūtra, Einaudi, Torino 2015.
D.G. White (a cura di), Yoga in Practice, Princeton University Press, Princeton 2012.
Altri testi consultati:
A. Leroi Gourhan, Le Geste et la Parole II La Memoire et les rythmes, A. Michel, Parigi 1964.
A. Leroi Gourhan, Milieu et techniques A. Michel, Parigi 1973.
T. Maldonado, Critica della ragione informatica, Feltrinelli, Milano 1997.
H. Plessener, I gradi dell’organico e l’uomo, Bollati Boringhieri, Torino 2006.
G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, Paris 1989.
G. Simondon, L’individuazione psichica e collettiva, Derive Approdi, Roma 2001.
G. Simondon, Sulla tecnica, Orthotes, Napoli-Salerno 2017.
Riferimenti immagini:
Wikipedia, Iyengar Yoga Source, https://publicdomainreview.org/collection/hatha-yoga-images-from-the-joga-pradipika/
© Associazione Iyengar Yoga Italia (AIYI), maggio 2025
Via Leonardo Fibonacci 27 50131 Firenze
Tel/Fax 055 674426
info@iyengaryoga.it
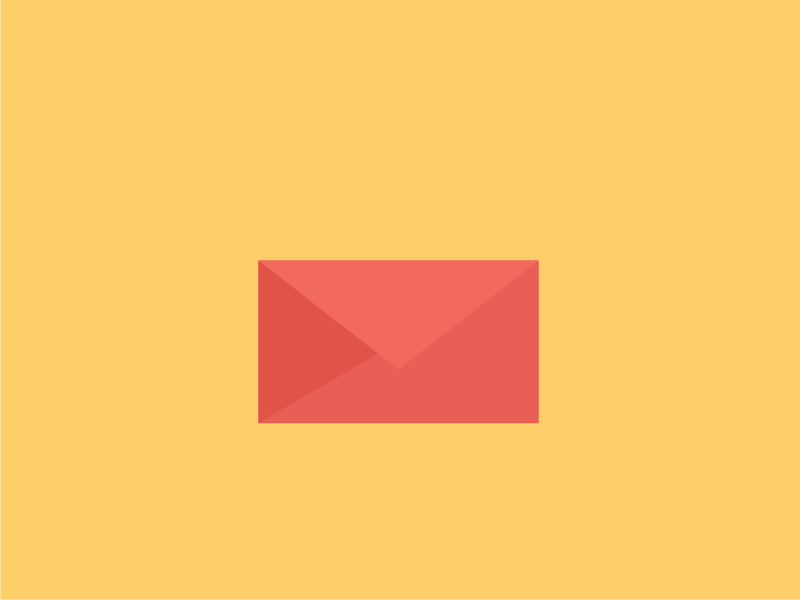
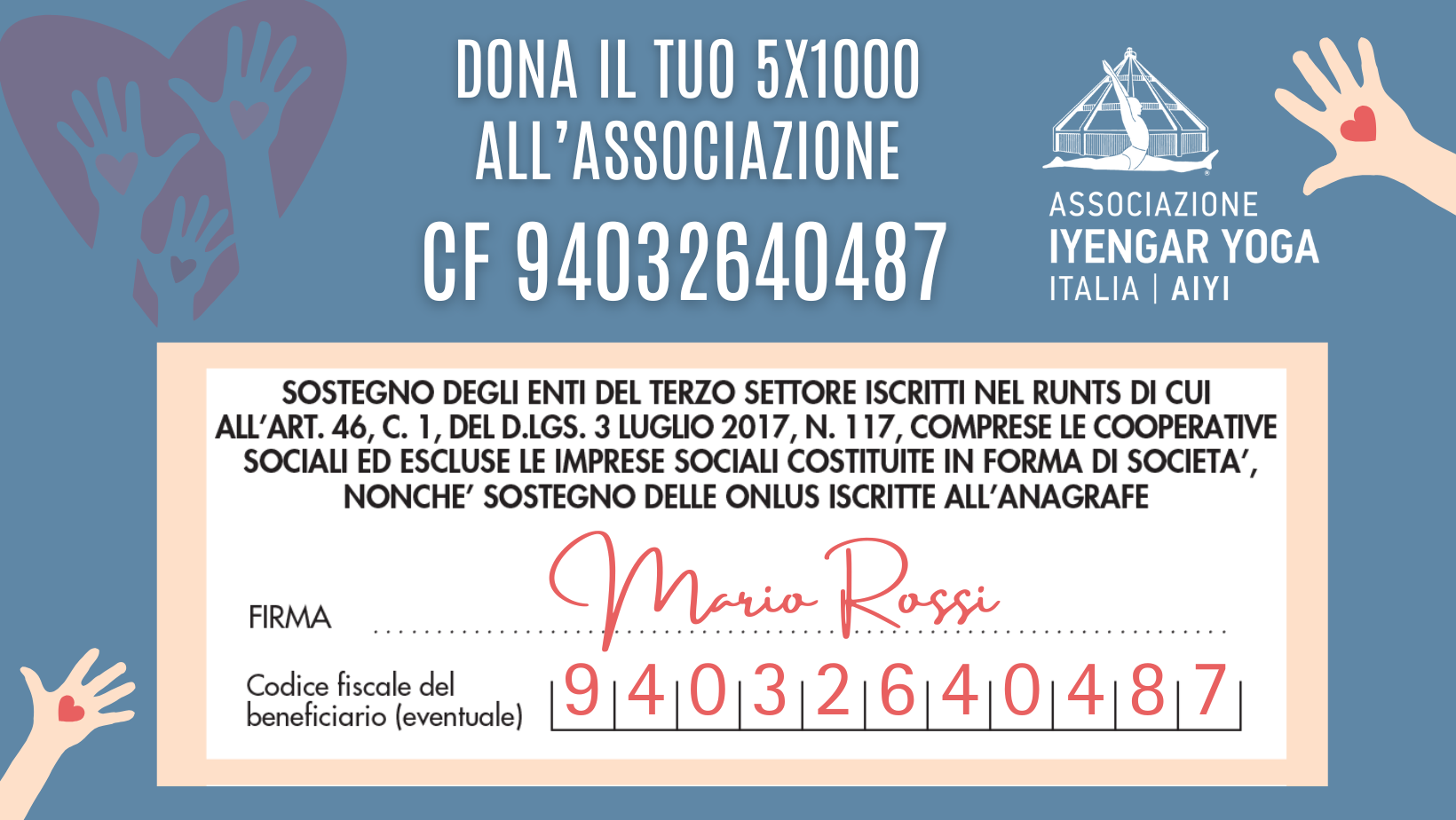
Via Leonardo Fibonacci, 27 • 50131 FIRENZE • Tel. 055-674426 • e-mail: info@iyengaryoga.it
Copyright © 2015 by IYENGAR® Yoga (Italy) • all rights reserved • privacy policy

